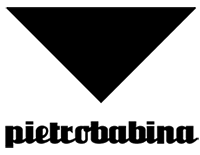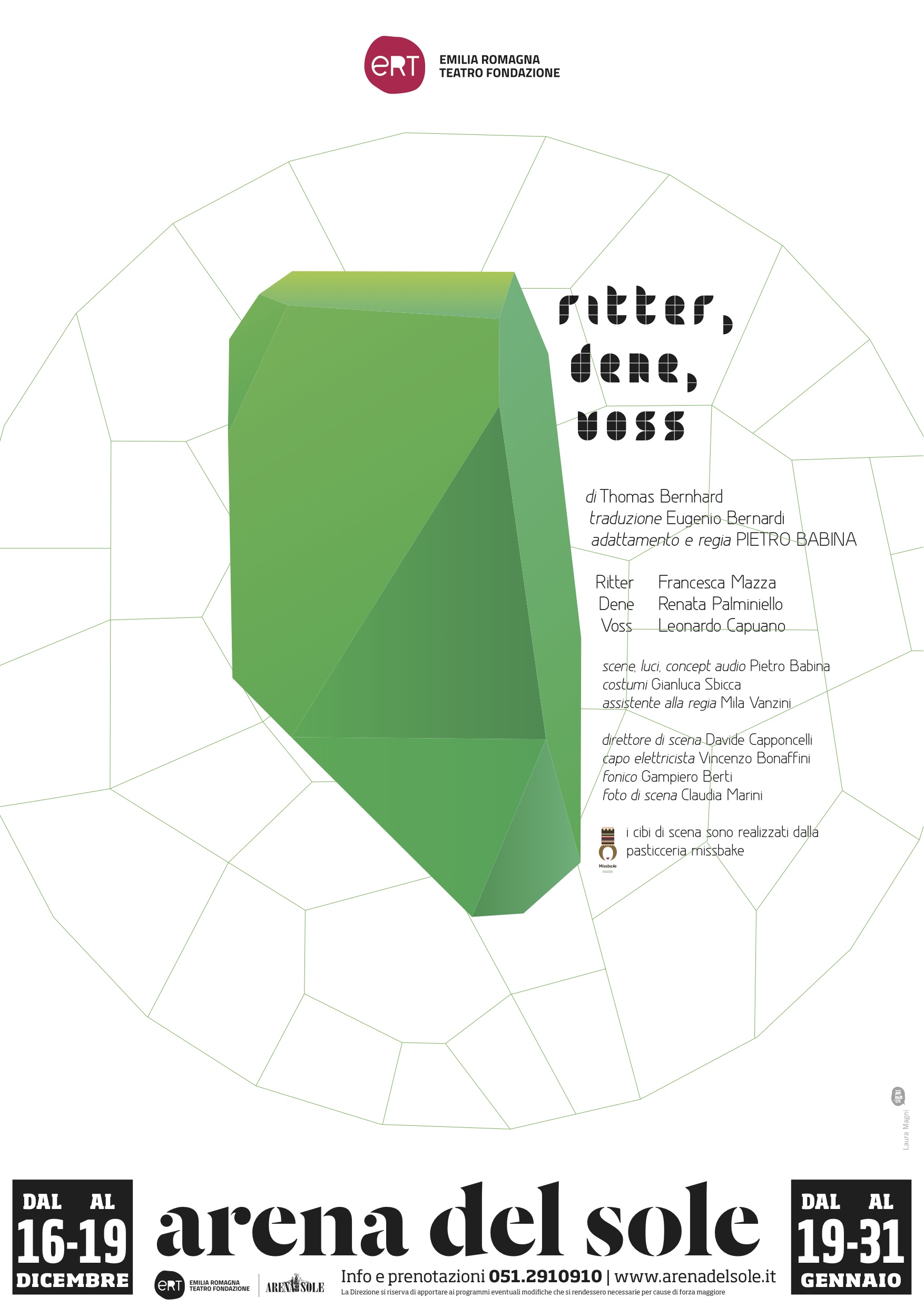di Thomas Bernhard
traduzione Eugenio Bernardi
adattamento e regia PIETRO BABINA
Ritter Francesca Mazza
Dene Renata Palminiello
Voss Leonardo Capuano
costumi Gianluca Sbicca
scene, luci, concept audio Pietro Babina
assistente alla regia Mila Vanzini
foto di scena Claudia Marini
i dolci di scena sono realizzati dalla pasticceria Missbake
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
Date 2015:
Prima Assoluta: 16 DICEMBRE 2015 –ARENA DEL SOLE, BOLOGNA
In scena: 16-19 DICEMBRE 2015 e 19-31 GENNAIO 2016 – ARENA DEL SOLE, BOLOGNA
08-17 GENNAIO 2016 – TEATRO DELLE PASSIONI, MODENA
SINOSSI. Tre fratelli e una sala da pranzo. Un pasto allestito dalla sorella maggiore, Dene, per accogliere il fratello filosofo Ludwig, riportato a casa dal manicomio di Steinhof contro il parere della sorella minore, Ritter. È il tentativo di ricostruire un nucleo familiare tra i tre fratelli, ma l’amore fraterno da lungo tempo si è ormai pervertito e tutto sfocia in un convulso scambio di feroci giudizi, rimproveri, sarcasmi e sentenze, concludendosi con il fallimento e il tradimento. Quello che in superficie appare come l’ennesimo quadro familiarborghese si rivela essere molto di più. I giudizi, pronunciati come coltelli, esondano da quel piccolo nucleo per divenire emblematici di una catastrofe più ampia, quella di una civiltà intera, quella occidentale. La trama diviene il supporto di numerosi livelli formali a partire da un linguaggio che, pur apparendo coerente, a lungo andare risulta folle, ossessivo, distruttivo, nichilista e tuttavia, nel suo eccesso, ferocemente comico.
Foto di Claudia Marini. Tutti i diritti sono riservati.
INTERVISTA AL REGISTA PIETRO BABINA
Come ti sei avvicinato all’opera di Thomas Bernhard e quali aspetti di lui ti hanno colpito di più? Come hai scelto di affrontare la scrittura bernhardiana?
I motivi che mi hanno spinto a scegliere un testo di Bernhard sono molteplici. Alcuni di questi sono assolutamente pragmatici ed altri sono più di carattere artistico e non posso dire che i secondi abbiano giocato un ruolo maggiore, tuttavia sono sicuramente quelli che in definitiva contano. Da lungo tempo sentivo la necessità, il desiderio di confrontarmi con un testo accettandone l’integrità e la sfida che questo comporta. Non ho mai partecipato sentimentalmente alla faida tra teatro di parola o di testo e teatro di immagine o altro. Certo nel tempo ho sempre cercato di comprendere quali implicazioni la presenza o l’assenza delle parole presentino nella creazione di un’opera teatrale, in tutti i miei lavori questa domanda era viva e allarmata, a volte per incapacità, a volte per convinzione ho dovuto escluderla, ridimensionarla, distorcerla, ma sempre sulla base di una dialettica in positivo. Di conseguenza la tensione alla sfida del testo come centro del problema (non in assoluto ma occasionalmente) non poteva per me, che ricadere su un testo di Bernhard, in cui la parola e la sua messa in discussione, i suoi paradossi, le sue aporie, le sue astrazioni convivono. Inoltre ritengo che il patrimonio testuale di Bernhard sia da considerarsi classico e di conseguenza farlo assurgere al grande privilegio che solo alcuni autori detengono, cioè quello di essere materiale teatrale con valenze universali, questa condizione mi ha reso possibile un approccio non reverenziale o da intenditore (attitudini entrambe che non mi si confanno) e, di conseguenza, di poter lavorare sul testo con una assoluta libertà interpretativa. Il vincolo dell’integrità del testo fa parte di una mia decisione aprioristica, come fosse uno dei temi del lavoro stesso.
Esistono affinità particolari che ti legano al drammaturgo austriaco?
Ho una passione per Bernhard sin dai tempi dell’accademia, infatti cercai allora, non senza ingenuità, di interpretare Minetti. Credo sia l’autore del 900 di cui ho posseduto per primo l’intera opera teatrale e credo da questo punto di vista sia rimasto l’unico a tutt’oggi sui miei scaffali assieme a Ibsen e Brecht e De Sade. Le ossessioni teatrali presenti e ricorrenti nei suoi testi le ho sempre sentite assolutamente mie, l’ossessione del teatro come argomento da trattare in scena, mi è particolarmente vicina, il continuo riflettere, disquisire, arrovellarsi, sul problema dell’arte e anche la sofferenza e l’insofferenza per l’arte e gli artisti o i sedicenti artisti e il «parassitame» che costella questi mondi, mi sono sempre apparsi argomenti miei e, non ultimo, anche il piglio con cui Bernhard tratta tutto questo mi è terribilmente affine sin da quando non avevo ancora fatto praticamente nulla, forse, non tanto nelle forme quanto nei pensieri è stato un autore a me sempre amico e presente.
Cosa ti ha spinto a scegliere l’opera Ritter, Dene, Voss? A cosa ti sei ispirato e che strada hai seguito per l’allestimento dell’opera?
Alcuni credono che lo abbia scelto per questioni di affinità autobiografiche essendo io il fratello di due sorelle di una famiglia borghese. Ma se questo dovesse essere in qualche parte vero è da attribuirsi al mio inconscio, sempre che esista. Io invece credo di averlo scelto per questioni più pragmatiche, diciamo che ho scelto Bernhard e di conseguenza ho cercato nel suo patrimonio un testo che sentivo di poter affrontare. La dimensione situazionale di Ritter, Dene, Voss mi si confaceva e anche il numero e il carattere dei personaggi. Ad oggi, visti gli attori con cui ho poi deciso di lavorare, penso che non avrei potuto fare scelta migliore.
Che metodo di lavoro adoperi per la preparazione delle tue messe in scene?
Da diverso tempo sono al lavoro per la definizione di un metodo. Negli ultimi anni ho messo a punto una serie di pratiche precise e definite di lavoro con l’attore, con la scena e con tutti gli elementi che costituiscono uno spettacolo. Ho costituito una serie di pratiche che mi permettono di iniziare un dialogo con gli attori su basi molto pragmatiche e di seguire un filo registico guidato da alcune idee fondamentali. Fondamentalmente non credo che la regia debba forgiare l’opera ma avere la giusta sensibilità per esprimerla, o meglio di fare sì ch’essa si esprima. Per fare questo è necessario compiere, in fase di prove, una serie di pratiche finalizzate all’accordatura dello strumento. Il mio compito nelle prime fasi è molto simile a quello di un accordatore. Non entro qui nel merito delle specifiche pratiche altrimenti ne risulterebbe una sorta di manuale. Posso però dire che il metodo si articola su tre fasi che per questioni di affinità amo definire con termini mutuati dalla musica. La fase dell’accordatura, la fase dell’esercitazione e la fase dell’interpretazione. Ognuna di queste fasi ha delle tecniche specifiche, ovviamente non a compartimenti stagni. La cosa più difficile è far convivere queste idee con i sistemi produttivi del teatro.
Come hai sviluppato i personaggi?
Il lavoro sui personaggi è molto lungo ed è una parte della fase di accordatura. Innanzi tutto andrebbero specificate alcune cose di carattere terminologico riguardo a ciò che si intende dicendo personaggio: come ben sappiamo questa figura è stata molto contestata nei passati decenni, e questo certo non senza motivi, così come il dramma e la rappresentazione, tuttavia non disconoscendo il senso di queste posizioni, sono convinto che ad oggi, superati gli ostacoli storici che rendevano necessarie asserzioni e negazioni assolute, si sia trattato solo ed esclusivamente di ridefinizioni di questi stessi problemi e trovo si debba ammettere che comunque la si guardi il personaggio il dramma e la rappresentazione restano essenzialmente i fondamenti costitutivi dell’opera teatrale, la reale eliminazione di questi, ci porta sempre all’extra teatrale e quindi a qualcosa che non è teatro ma altro. Questi eventuali sconfinamenti se ricondotti all’esperienza teatrale sono utili, diversamente viene un momento in cui è necessario comprendere cosa si stia realmente facendo. Sulla questione del personaggio potrei dire che sarebbe forse più giusto usare il termine “impersonante”, ma in fondo non si tratterebbe che di una specifica se non di un sofisma. Per me tutto ciò che appare sulla scena è personaggio, sia che la sua natura sia umana, animale, vegetale o materiale ed è per questo che il primo passo da compiere è sempre un lavoro di accordatura. Tutti coloro che appaiono in scena devono essere accordati ancor prima di compiere qualunque tipo di azione drammaturgica.
Con alcuni degli attori di Ritter, Dene, Voss ti eri già confrontato professionalmente, come è stato dirigerli tutti assieme in questa occasione e che metodo hai usato?
Come ho già detto all’inizio si trattava di accordare tutti gli elementi e anche gli attori fanno parte di questa accordatura, ho quindi ideato una serie di compiti e di esercizi di vario genere che ho sottoposto agli attori. Sono stati realizzati circa una ventina di incontri propedeutici, sia singoli che di insieme, durante i quali mi sono limitato quasi esclusivamente a fare delle domande, ad ascoltare quello che, attraverso gli esercizi, gli attori costruivano, pensavano, intuivano. Ovviamente le mie domande hanno una funzione specifica, non sono mai assolutamente neutrali, tendono all’accordatura e quindi, seguendo le intuizioni che scaturiscono dagli attori, si inanellano per far convergere tutti verso punti comuni ma non imposti, o per lo meno non imposti da una visione registica preconcetta. Questo metodo tuttavia è in grado di condurre le cose in determinate direzioni, non c’è da parte mia un abbandono di responsabilità, anzi, ho potuto sperimentare che portare un attore a concepire il da farsi – il concepire non il capire – cambia completamente la qualità della sua presenza e anche della sua partecipazione alla creazione dell’opera che deve, in fondo, essere lo scopo di tutti e non solo del regista. Abbiamo fatto molte cose e molti esercizi e non abbiamo smesso di seguire questo metodo nemmeno durante le prove. Potrei fare degli esempi ma risulterebbero incomprensibili fuori dal percorso.
Che influenza hanno la musica e la scenografia nelle tue messe in scene?
Sono fondamentali come tutto il resto, sono anch’esse «personaggi» e come tali vanno curate e accordate con tutto e come tutto. La musica poi, anche quando non è esplicitamente presente, è per me un elemento fondante: come ho detto più volte credo di costruire le scene più secondo una sensibilità sonora che visiva. Tutto deve suonare assieme e quindi per me la musica c’è anche quando non la udiamo, è la guida sommersa di ogni cosa sulla scena, ma senza confonderla con la drammaturgia.
È da oltre vent’anni che ti occupi di teatro, cosa è cambiato dal 1990 a oggi nel tuo “modo” di fare teatro? E cosa pensi che sia cambiato nell’ambiente che circonda il teatro e nel modo di rappresentarlo?
Tutto e niente, in entrambe i casi. In fondo non si tratta che di parabole, di strutture cosmiche circolari. Là dove il problema è l’Arte sembra sempre riprodursi la medesima situazione, l’arte non è la cultura è esente da problemi temporali. Non credo nel problema dell’utilità dell’arte e assolutamente non credo nella possibilità di un’arte contemporanea, questo è un concetto privo di qualsiasi senso per me. L’arte è tale sempre, nel passato, nel presente e nel futuro. In questo c’è una grande potenza. La tensione è sempre e solo in ogni momento quella di essere in grado di compiere un gesto che sia d’arte, per il resto si tratta di problemi o di mercato, o di ego o di politica, tutte cose secondarie in arte. Ho cambiato molte volte direzione o metodo ma esclusivamente perché mi sembrava che l’opera lo richiedesse e non perché me lo richiedesse il contemporaneo o il mio ego o l’attualità. Non nego di essermi confuso a volte, ma tutto il tempo passato e l’esperienza mi hanno portato a queste convinzioni chiare e in fondo molto semplici.
Link:
www.emiliaromagnateatro.com
www.arenadelsole.it